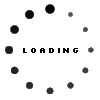Il considerevole patrimonio confiscato ai gesuiti non fu, per motivi di opportunità politica, incamerato dall’erario, ma fu destinato agli stessi scopi che la Compagnia di Gesù aveva perseguito, e cioè l’organizzazione delle scuole e l’assistenza ai poveri. Fu deciso di alienare gli immobili di proprietà dei gesuiti per dimostrare che l’espulsione era un provvedimento definitivo ed irrevocabile, ma, essendo difficile trovare dei compratori, trattandosi di grosse proprietà, si ricorse all’enfiteusi (affitto perpetuo con obbligo di miglioria), che dava allo stato modesti guadagni, ma garantiva l’accesso allo sfruttamento di questi beni anche a gente non benestante. In questo clima maturò l’idea di attuazione della piccola proprietà contadina, progetto ispirato dall’insegnamento del filosofo napoletano Antonio Genovesi, con la divisione delle terre in piccoli appezzamenti dati in enfiteusi a contadini che si obbligassero a costruirvi l’abitazione con l’aiuto finanziario dello stato. Si sperava, così, di ripopolare le campagne e di fare aumentare la produzione agricola.
Tali provvedimenti del Tanucci furono resi operativi dal dispaccio reale del 25 marzo 1768, che incontrò l’opposizione dei baroni e del vicerè Fogliani. Nonostante le opposizioni, la legge fu applicata, ma i baroni riuscirono egualmente ad accaparrarsi grosse estensioni di terra togliendole ai contadini.
Fu, dunque, necessario emanare un secondo e più rigoroso regolamento della censuazione dei beni ex-gesuitici sei anni più tardi, il 15 giugno 1773, che è il primo organico provvedimento di colonizzazione del latifondo meridionale ed il più consistente programma di riforma agraria realizzato in Italia nel corso del ‘700. Furono concessi a 3.229 famiglie contadine ben 28.625 ettari di terra divisi in lotti, mentre 6.000 ettari furono concessi con il sistema a corpo e 10.000 ettari furono venduti.
Complessivamente furono alienati oltre 45.000 ettari del patrimonio dei gesuiti e l’operazione si arrestò per la caduta del Tanucci, sostituito dal marchese della Sambuca, che manifestò un orientamento politico diverso. Gli effetti della riforma tanucciana rimasero, comunque, consistenti, perchè fecero maturare nei contadini una presa di coscienza, che rompeva il blocco baroni-contadini e che suscitava l’indignazione dei baroni, che vedevano diminuire il loro potere sui contadini. Questo nuovo stato di cose influenzò alcuni avvenimenti successivi.
Il primo di essi fu la rivolta di Palermo dell’ottobre del 1773, che apparentemente fu scatenata dai capi delle corporazioni artigiane, ma che, per le modalità di attuazione e per i risultati conseguiti, si sospettò fosse appoggiata dai nobili e dagli espulsi gesuiti.
Palermo era la più grande città d’Italia, dopo Napoli, e con i suoi 200.000 abitanti aveva avuto un incremento demografico superiore a quello di Roma, Milano, Torino. Vi abitavano molti aristocratici in lussuosi palazzi e popolani in agglomerati di baracche, mentre modesto era il numero dei borghesi, che erano soprattutto funzionari governativi e professionisti; mancava il ceto imprenditoriale ed il porto di Palermo era poco frequentato.
Il vicerè teneva a bada la nobiltà colmandola di titoli e di onorificenze e particolare cura era riservata all’organizzazione delle feste cittadine: feste religiose, corride, festa di carnevale. Particolare importanza rivestiva, per lo sfarzo con cui era organizzata, la festa di S. Rosalia, i cui festeggiamenti duravano cinque giorni con fuochi d’artificio e processioni, che vedevano i palermitani straordinariamente uniti e concordi.
Una parte importante nella vita della città avevano le 72 corporazioni artigiane, che influenzavano la politica, soprattutto nei momenti di emergenza. Esse stabilivano tra di loro accordi per instaurare una sorta di monopolio ed erano gelose dei loro privilegi, come quello di portare armi, di poter andare a caccia nei boschi intorno a Palermo, di svolgere mansioni di forza ausiliaria di polizia e di presidiare le fortificazioni della città.
Così facendo li si staccava dal "basso popolo" per introdurli nella schiera dei privilegiati.
Nel un’ulteriore cattiva annata scatenò la protesta popolare contro il Fogliani e, quando circolò la voce che il vicerè stava facendo affluire truppe a Palermo, le maestranze intervennero a rivendicare il loro antico diritto a difendere le porte della città e si precipitarono a presidiarle, per impedire ai nobili di uscire ed all’esercito di entrare, rivelandosi la forza più efficiente dell’isola. Il popolo, vedendo il fronte dei conservatori spaccato, diede vita ad una guerriglia contro le autorità, saccheggiando magazzini ed attaccando minaccioso la nobiltà.
Palermo era stata spesso teatro, nel passato, di ribellioni, ma non era mai accaduto che gli insorti si impadronissero del governo della città con la connivenza della classe dominante. Il vicerè Fogliani fu esautorato, l’esercito fu messo nell’impossibilità di agire e fu istituito un governo provvisorio nella persona dell’arcivescovo Serafino Filangieri, zio di Gaetano, filosofo napoletano. La rivolta avrebbe potuto estendersi a tutta l’isola, ma non vi fu nessuno che mostrò interesse in tal senso; apparve chiaro che l’intento dei baroni non era di ribellarsi al dominio borbonico, ma di dimostrare al ministro Tanucci che in Sicilia non si poteva governare senza l’appoggio dei nobili. In realtà l’atteggiamento nobiliare confermò la teoria politica del Tanucci, secondo cui la sovranità, per avere solide basi, deve poggiare sulle masse e non su pochi individui potenti.
Fu l’intervento delle maestranze a salvare la situazione, come nel 1647 e nel 1708. Esse ristabilirono l’ordine, che era la condizione indispensabile per le loro attività ed i loro guadagni, assunsero le funzioni della polizia e della magistratura, rifiutando l’aiuto dell’esercito, e ripulirono la città da rivoltosi e delinquenti. La nobiltà riconquistò gradualmente il potere nell’arco di un anno e le maestranze furono esautorate, mentre la delinquenza ritornava ad imperversare.
La monarchia borbonica, però, continuò la sua politica antinobiliare, mostrando chiaramente di voler imbrigliare la turbolenta aristocrazia. A Napoli si diffuse la sensazione che la fedeltà della Sicilia in generale e dei baroni in particolare fosse aleatoria, ma, dietro suggerimento del Tanucci, si evitò di usare mezzi forti, che rischiavano di portare alla guerra civile ed alla distruzione di quella che era la seconda città del regno. Fu usata, dunque, la clemenza, e la suprema potestà in Sicilia fu gestita insieme dall’arcivescovo Filangieri, che si stabilì a Palermo, validamente assistito dal ministro Targiani, e dal vicerè Fogliani, che si stabilì a Messina. Rimase vivo, comunque, a Napoli un orientamento antisiciliano ed antibaronale, che ebbe notevole peso negli anni successivi.