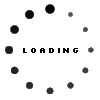Durante la reggenza (1759 – 1767) il Tanucci, che era componente del Consiglio di Stato che la esercitava, cercò da un lato, seguendo le direttive di Madrid, di contenere il più possibile la tendenza dei baroni ad usurpare le prerogative reali, dall’altro cercò di responsabilizzare l’aristocrazia, richiamandola alla sua funzione di classe egemone. Era un gioco di equilibrio assai difficile e, alla fine della reggenza, la nobiltà apparve pericolosamente rafforzata in entrambi i regni.
Durante tale periodo rivestì una posizione di particolare potere in seno al Consiglio di Stato il siciliano principe di Camporeale, sostenuto dai principi napoletani Sannicandro, Centola e Sangro; egli si contrappose validamente al Tanucci, sostenuto da Michele Reggio e dal principe di Aci. In questo periodo la nobiltà siciliana svolse un ruolo egemone, che si evidenziò nella richiesta della costituzione di una milizia nazionale, comandata esclusivamente da ufficiali nobili e del licenziamento delle truppe mercenarie svizzere, che dipendevano direttamente dal re. Era una richiesta che, se accolta, rischiava di mettere il re alla mercè dei baroni ed il Tanucci, nel respingerla, suscitò l’opposizione sia dei Napoletani, che dei Siciliani.
In politica economica i baroni, grandi produttori e commercianti di grano e di derrate agricole, erano sostenitori di una politica commerciale liberalista, che ben si conciliava con la difesa dei loro interessi. L’incremento demografico del regno delle Sicilie e dell’Europa aveva creato, con l’accresciuta domanda, condizioni favorevoli al commercio delle derrate alimentari, sicchè in Sicilia era aumentata di molto l’estensione delle terre coltivate e così pure la produzione cerealicola, di cui una quota consistente era destinata all’esportazione. Secondo dati approssimativi la superficie coltivata era in Sicilia di 600 mila salme (la salma è una misura di superficie in uso in Sicilia pari a 4 ettari circa), di cui 200 mila seminate a grano, 200 mila a pascolo per il necessario riposo e 200 mila preparate per la semina dell’anno successivo; si ha, però, motivo di ritenere che queste cifre siano inferiori alla realtà. In ogni caso il quadro produttivo forniva la disponibilità di almeno 200 mila salme di grano all’anno per l’esportazione all’estero, pari ad un valore di un milione e mezzo di scudi, che davano alla Sicilia la fisionomia di un paese fortemente esportatore di grano.
Nonostante il grano siciliano avesse costi di produzione elevati, e comunque superiori a quelli della Calabria, della Puglia e di altri paesi esteri, a causa della mancanza di strade carrozzabili e dell’arretratezza organizzativa dell’agricoltura, la grande richiesta proveniente dall’estero garantiva lo smercio del grano disponibile. Il commercio del grano era interamente gestito dalla nobiltà con il sistema dei caricatoi, grandi magazzini di raccolta situati nei principali porti dell’isola. Il conflitto tra baroni e governo nasceva dal fatto che i baroni avrebbero voluto disporre liberamente del grano prodotto, determinandone il prezzo di vendita, mentre il re concedeva loro di esportare il grano dopo che era stato assicurato il fabbisogno annonario di Palermo, Napoli, Madrid a prezzi non troppo elevati; prezzi speciali erano, inoltre, previsti per l’esercito e la marina, ed anche la scelta dei paesi verso cui dirigere l’esportazione era di pertinenza del governo. La questione fu causa di continui contrasti tra baroni, sostenitori della liberalizzazione, e governo regio.
Un settore in cui la nobiltà aveva notevolmente rafforzato la sua presenza in Sicilia era quello ecclesiastico; la legge di riforma del 1738 prevedeva, infatti, che la direzione delle chiese di regio patronato fosse riservata a prelati siciliani. Era stata una disposizione che aveva consentito ai figli cadetti dei nobili, che spesso vestivano l’abito talare, di crearsi una posizione prestigiosa in seno alla Chiesa, infatti i nobili poterono occupare e detenere quasi completamente, da allora in poi, le leve di comando della Chiesa in Sicilia, ricoprendo le cariche di vescovo ed arcivescovo, ed un arcivescovo di Sicilia, Antonino Colonna Branciforte, ebbe persino la tiara cardinalizia.
Nel parlamento siciliano, poi, i titolari delle abbazie di regio patronato che ne facevano parte erano tutti appartenenti alla nobiltà, sicchè si può dire che, se Chiesa e nobiltà in Sicilia erano state sempre strettamente legate, adesso il gruppo dirigente dell’alto clero era una sezione della nobiltà. Scriveva il Tanucci al re il 12 giugno 1764: "queste ricche badie non servono più ad alcun buon uso; si danno ad ecclesiastici finti, cioè senza dottrina e senza santità. (…) Non solamente sono inutili per la religione e per lo stato, ma sono dannosi e pieni di pretenzioni e d’inquietudine".
Altro settore in cui la nobiltà dominava era l’esercito, in seguito alla legge del 1738, che ne prevedeva l’inserimento nei posti di comando.