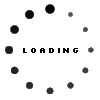Il vicerè Ossuna (1610-1615) si fece promotore di una politica di risanamento fiscale, tesa ad equilibrare entrate ed uscite, ma questo obiettivo fu perseguito con l’aggravio fiscale delle città, mentre non furono intaccate le rendite parassitarie del ceto nobiliare.
A queste misure si lega, quindi, la popolarità di cui presso questi ceti godette Ossuna, che riuscì a stabilizzare l’economia della Sicilia senza intaccare i loro privilegi, ma ponendo una seria ipoteca sul futuro dell’isola, dal momento che la base produttiva si restringeva sempre più. Era una politica miope, priva di prospettive di lungo periodo, ma che consolidava la fedeltà alla monarchia dei ceti sociali privilegiati, fruitori di rendite parassitarie ed improduttive, che saranno i protagonisti della storia siciliana del ‘600. A mascherare una politica fiscale tesa alla difesa dei privilegi nobiliari Ossuna provvide con uno stile pubblico paternalistico e magnificente, con feste popolari frequenti e dispendiose.
L’agricoltura della Sicilia, che dopo il 1559 aveva goduto per trent’anni di condizioni climatiche favorevoli alle colture del grano e della vite, iniziò dopo la carestia del 1591 ad essere colpita per almeno 15anni da annì da una serie cattivi raccolti. La conseguenza sul piano sociale fu che l’agricoltore siciliano (burgisi), che negli anni felici era padrone dei suoi attrezzi di lavoro, dopo la carestia del 1591 fu costretto progressivamente ad indebitarsi con il proprietario o con il gabelloto, che gli fornivano sementi e denaro, e la quasi totalità del raccolto era impegnata nel rimborso di queste anticipazioni, mentre si riduceva sempre più il surplus commercializzabile. La sua condizione si fece sempre più subordinata e priva di autosufficienza, sì da essere in tutto simile a quella del colono.
In questi anni si registrò in Sicilia da un lato la caduta della produzione granaria e l’estendersi del pascolo, dall’altro la caduta del prezzo del grano, a livello internazionale, collegata alla concorrenza del mercato baltico-atlantico dei frumenti, che ebbe un’accelerazione con la carestia del 1591. La Sicilia cessò di essere il granaio d’Italia ed a stento riusciva a coprire il fabbisogno di grano della sua popolazione.
Lungo tutto il ‘600, dietro pressione dei baroni, il governo adottò in Sicilia una politica di tipo coloniale, già applicata nei possedimenti americani e nella Castiglia, che consisteva nell’attrarre i ceti poveri della città verso la campagna, dove nascevano centri abitati, sui quali dominava il feudatario, che avevano come centro aggregante la chiesa e la piazza. Le case, costruite dal signore, venivano date ai richiedenti in vendita o "a censo", e così pure veniva dato un appezzamento di terreno.
Tale progetto mirava ad attirare i disperati della città, allo scopo di incrementare lo sfruttamento della terra, ed infatti la sua attuazione determiò’ una migliore distribuzione demografica in Sicilia. Esso, però, aveva un grosso limite nell’insopportabile peso dell’indebitamento che il colono si assumeva per la casa, per il terreno e per i servizi indispensabili, indebitamento che il signore si faceva pagare con meccanismi usurari, che privavano il contadino del surplus commercializzabile. Una nuova epidemia di peste nel 1624 colpì la Sicilia, contribuendo ad aggravare i suoi non pochi problemi.
La politica della Spagna a partire dal 1622 seguì in misura più ampia e generalizzata il criterio tracciato dai governi precedenti di ripartire sui vari domini della corona i costi di un rilancio della Spagna nella grande politica. In Sicilia, dove il vicerè Ossuna (1610-1615) e il vicerè Castro (1616-1621), la stessa linea politica di Olivares, erano riusciti ad aggregare i gruppi dominanti in un blocco di interessi intorno alle rendite del debito pubblico, che garantivano stabilità ed equilibrio sociale, questi gruppi videro con preoccupazione che il denaro rastrellato in Sicilia con la pressione fiscale delle città prendeva la via della Spagna e temettero l’insolvenza della Tesoreria regia.
La diffidenza serpeggiava nella classe nobiliare, che si rendeva, però, conto che per opporre resistenza alle sempre nuove richieste di donativi e all’imposizione di tributi da parte dello stato occorreva l’appoggio delle forze popolari, quelle stesse che erano state estromesse dalle decisioni politiche ed amministrative.
Da una Relacion del 1651 si evince che nel periodo 1630-’43 dalla Sicilia furono trasferiti a Milano e Genova 7 milioni di scudi, risorse che la Sicilia non era in grado di ricostituire. Il 22 giugno 1638 il parlamento, per soddisfare la pressante richiesta di 2 milioni da parte di Filippo V, impegnato nella guerra in Italia, votò l’imposizione della tassa "testatica", secondo cui chiunque vivesse di rendita o del proprio lavoro doveva versare all’erario l’equivalente del guadagno di una giornata.
Il drenaggio di somme sempre più cospicue impoverì la Sicilia e determinò il tramonto del vecchio baronaggio "nazionale", dal momento che la svendita dei titoli nobiliari, iniziata con il vicerè Olivares, aveva dato vita ad una "nuova" nobiltà, quella degli uffici e della finanza, che adesso era il nuovo spregiudicato interlocutore del potere centrale. Il parlamento non era piu’ sede di decisioni politiche, ma di operazioni finanziario-speculative.
La "nuova" nobiltà, chiamata a sostituire il vecchio baronaggio, che era stato la tradizionale classe di governo, dotata di senso dello stato e non corrotta dagli affari, non si pose l’obiettivo di conquistare il prestigioso ruolo della classe che era chiamata a sostituire. Con la dissoluzione dell’apparato "nazionale" di potere, senza che ad esso si sostituisse una valida alternativa culturale, si arrestò la continuità della tradizione politica siciliana, che registrò il più totale scompaginamento del suo sistema politico.