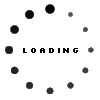La remunerazione del lavoro nelle miniere, patti verbali che davano vita a forme di soggezione morale e sfruttamento interoperaio, abusi e vessazioni di vario genere: paghe dilazionate, bottega usuraia, frodi nella pesatura del minerale estratto, estorsioni, penalità eccessive ed arbitrarie, lavoro malsano e pericoloso.

Rotaie e carrello distrutti della miniera Trabonella di Caltanissetta – Foto di Vincenzo Santoro
Il lavoro nelle miniere era, generalmente, remunerato a cottimo, tranne che per alcune categorie di operai addetti ai lavori di manutenzione, alla manovra delle pompe e ad altri lavori non misurabili, che venivano remunerati a giornata. La ragione del sistema del cottimo è da vedersi nella difficoltà di vigilanza all’interno delle miniere, spesso tecnicamente disorganizzate. Solo qualche zolfara razionalmente coltivata e bene organizzata usava il salario a giornata.
Nelle miniere con trasporto a spalla, sistema adottato generalmente fino al 1880, il gabelloto, cioé l’esercente, contrattava con i picconieri il compenso per ogni "cassa" di zolfo, che era l’unità di misura adottata. Nel compenso era compreso l’abbattimento del minerale ed il trasporto all’esterno. Ogni picconiere ingaggiava da due a quattro "carusi", che dipendevano esclusivamente da lui ed erano pagati a cottimo, con l’obbligo di un determinato numero di viaggi.
Questo rapporto di lavoro dava luogo ad una forma di sfruttamento interoperaio, che prendeva il nome di patto del "soccorso morto". Ragazzi spesso di età inferiore ai 14 anni venivano affidati dalla famiglia al picconiere, per essere adibiti al trasporto del minerale dal sotterraneo alla superficie con remunerazione a cottimo. La famiglia del ragazzo, essendo quasi sempre in stato di bisogno, si faceva dare dal picconiere degli anticipi, che non venivano quasi mai restituiti, anzi crescevano di settimana in settimana, fino a raggiungere in pochi anni le 200-300 lire. A questo punto il ragazzo restava fortemente vincolato al picconiere ed era obbligato a fare il trasportatore presso di lui fino a che non avesse scontato il debito. E non era raro il caso di operai di 30-40 anni rimasti "carusi" perché non avevano ancora restituito il "soccorso morto".
Il patto del "soccorso morto" (morto perché non produceva interessi) vincolava, dunque, fortemente il "caruso" al picconiere ed aveva origine dalla grande carenza di trasportatori, che faceva nascere tra i picconieri una grande concorrenza per accaparrarseli.
Talvolta al picconiere che aveva dato il primo anticipo se ne sostituiva un altro, che rimborsava al primo il "soccorso morto". In questo caso doveva esserci il consenso del "caruso", il quale lo dava, generalmente, dietro un aumento dell’anticipo. Il picconiere non poteva opporsi al cambio, ma, quanto più crescevano gli anticipi dati dal picconiere, tanto più cresceva la schiavitù del trasportatore, che si trovava nell’impossibilità di restituirli. Questo legame andava al di là del rapporto di lavoro e diveniva soggezione morale.
Il patto del "soccorso morto" era, dunque, un espediente per procurarsi a buon mercato una prestazione di opera, che sarebbe stata di gran lunga più costosa se i picconieri avessero dovuto contendersela giornalmente sul libero mercato del lavoro.
Esso, inoltre, ostacolava il passaggio del "caruso" dagli strati inferiori del lavoro a quelli superiori, poiché, se aveva la capacità di diventare picconiere, poteva diventarlo dopo aver restituito il "soccorso" e, nell’impossibilità di farlo, restava "caruso" fino a 30-40 anni.
Non era, però, infrequente il caso di genitori scorretti che, dopo aver riscosso il "soccorso morto" da più di un picconiere, si riprendevano il figlio senza alcuna restituzione e lo portavano a lavorare nei campi. Per il picconiere, che magari aveva dato in pegno la sua casa per pagare il "soccorso" ai carusi, era un grosso danno. La legge in questo caso proteggeva il "caruso", dato che il contratto tra picconiere e "caruso" era solo verbale ed il picconiere non aveva nessuna arma per fare valere il suo credito.
L’istituzione del Sindacato infortuni nel 1904 agevolò l’affrancamento dei "carusi", che talvolta ricorrevano all’autolesione per pagare con l’indennità ricevuta il debito del "soccorso".
Nel 1880 i fanciulli inferiori ai 15 anni che lavoravano in miniera erano 6.170 su 21.550 operai; nel 1900 erano 8.063 su 38.044 operai. La legge 11 febbraio 1886 vietò l’impiego di fanciulli di età inferiore a 10 anni nei lavori sotterranei ed a 9 anni nei lavori esterni. La legge 10 novembre 1907, n.818 sul lavoro delle donne e dei fanciulli fece migliorare notevolmente la situazione vietando l’impiego di fanciulli di età inferiore ai 14 anni.
Nel dopoguerra le condizioni di lavoro dei "carusi" migliorarono, infatti nel 1920 guadagnavano la metà di quanto guadagnava il picconiere, mentre prima della guerra ne guadagnavano un terzo, cioé 1,20-2 lire al giorno, e la loro giornata lavorativa scese a 6-8 ore, mentre prima era molto più lunga. Nelle grandi miniere, provviste all’esterno di mezzi meccanici per il trasporto del minerale, che veniva fatto con vagoncini, il lavoro dei "carusi", che trasportavano il minerale dal posto di escavazione fino alla galleria di carreggio, era meno faticoso.
L’affrancamento dei "carusi" fu facilitato nel dopoguerra dalla grande richiesta di manodopera nell’agricoltura e nell’artigianato, che allontanava sempre più gli operai dal lavoro disagiato e malsano delle zolfare. Risentì dello scarseggiare dei "carusi" la piccola e media industria sprovvista di mezzi meccanici e legata alla necessitì del trasporto a spalla.
Gli operai venivano pagati ogni due o tre mesi e questo era motivo di frequenti scioperi, quando gli intervalli tra una paga e l’altra si facevano troppo lunghi. Nelle amministrazioni meglio organizzate si soleva dare un acconto il 15 di ogni mese e il saldo a fine mese. Nei periodi di crisi il pagamento dei salari ritardava ancora di più.
Per sopperire ai bisogni giornalieri degli operai, ogni gabelloto impiantava nella sua miniera una bottega, la cosiddetta "cantina", tenuta da un prestanome, che forniva a credito agli operai un po’ di tutto, dal pane alla polvere da sparo. Il sistema era, però, degenerato in uno sfruttamento inumano, sia perché i generi erano di cattiva qualità, sia perché venivano conteggiati sulla paga a prezzi vergognosamente elevati.
Le larghe dilazioni tra una paga e l’altra, mettendo lo zolfataro nella necessità di comprare a credito, rendevano possibile questo inumano sfruttamento (truck-system). La bottega, facendo leva sui pagamenti ritardati a bella posta e sul bisogno dello zolfataro, che per tutta la settimana era lontano dal paese, era, dunque, il mezzo di cui il gabelloto si serviva per ridurre il salario del minatore e aumentare il proprio profitto.
Ma, oltre alle paghe dilazionate ed alla bottega usuraia, l’operaio era soggetto ad altri abusi e vessazioni, come, ad esempio, frodi nella pesatura del minerale estratto, estorsioni e camorre di capimastri e sorveglianti, conteggi falsi, penalità eccessive ed arbitrarie, licenziamenti in tronco senza alcuna giustificazione, lavoro malsano e pericoloso per negligenza o avarizia dell’industriale.
Gli infortuni sul lavoro erano frequenti nelle zolfare ed erano causati, oltre che dalle condizioni naturali di per sé pericolose, dalla negligenza dell’esercente e degli operai stessi.