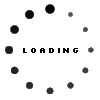L’obiettivo che Carlo III ed i suoi ministri si posero fu quello di instaurare uno stato assoluto e forte, ma si trovavano ad operare in un territorio dove per tradizione le normali prerogative dello stato erano appannaggio del clero, del baronaggio, delle comunità territoriali e degli stessi organi amministrativi e giudiziari, che formalmente dipendevano dal re.
In Sicilia esistevano le premesse per il consenso alla costituzione del nuovo stato indipendente, anche se esso la vedeva unita a Napoli, che era il vero centro; infatti i Siciliani non rimasero insensibili di fronte al richiamo che i nuovi governanti facevano al normanno re Ruggero, fondatore della monarchia siciliana, ed in ogni caso guardavano con consenso ad una monarchia che si presentava come una realtà politica italiana, anche se di origine spagnola. Bisognava, però, pervenire allo stabilimento di una parità giuridica tra i due regni, perchè si instaurasse un rapporto di interdipendenza, e non già di dominanti e dominati, superando il modello statuale spagnolo, che si presentava inadatto.
Il problema presentava due aspetti in sè contraddittori: da un lato il re si era impegnato con giuramento a rispettare in Sicilia il quadro istituzionale vigente, che era caratterizzato dall’assenza di un forte potere centrale; dall’altro, per fondare una monarchia assoluta e forte, doveva creare nuovi istituti di accentramento, che fatalmente dovevano soppiantare i precedenti.
In quanto al rapporto esistente tra i due regni, formalmente essi erano indipendenti l’uno dall’altro, nel senso che elementi siciliani non potevano essere assunti nell’amministrazione del regno di Napoli ed elementi napoletani in quello di Sicilia. Di fatto, dal momento che Napoli era la sede del governo regio, i Siciliani potevano essere chiamati a svolgere funzioni direttive nelle segreterie di stato e nell’esercito, a ricoprire incarichi diplomatici all’estero. Essi avevano, quindi, possibilità di partecipare alle funzioni dei vertici dello stato, mentre ai Napoletani era fatto divieto di ricoprire cariche di vertice nell’amministrazione viceregia in Sicilia, tranne quelle di consultore e di segretario del regno. Di conseguenza il primo ministro del re poteva essere siciliano, ma il vicerè di Sicilia non poteva essere nè siciliano, nè napoletano, ma di altri territori italiani o straniero. Fu in questo intricato groviglio che i Borboni dovettero operare per la costituzione di uno stato assoluto centralizzato, pur nel rispetto dell’autonomia dei due regni.
Non meno intricato era il rapporto tra Regno delle Sicilie e Chiesa di Roma, del cui appoggio il regno aveva bisogno in dipendenza della sua condizione di vassallo della Santa Sede, che era, tra l’altro, di ostacolo all’esercizio di vera sovranità. Solo nel 1738 Carlo III ottenne l’agognata investitura, tramite le pressioni esercitate anche dalla Spagna.
La presenza del clero in Sicilia era assai consistente (si calcola che c’era un convento o un monastero per ogni 1.000 abitanti); nella sola Palermo, che contava circa 100.000 abitanti, il 9% circa della popolazione era costituito da gente di chiesa, che compenetrava di sè in vario modo tutta la struttura sociale. La stessa situazione esisteva a Messina e Catania, dove la curia vescovile aveva un rapporto di patronato con la locale università statale, l’unica operante in Sicilia nel ‘700. Chiese e conventi godevano di immunità e privilegi, tra cui il diritto di asilo, che limitavano fortemente i poteri dello stato e le sue funzioni di controllo sociale.
Assai consistente era il patrimonio ecclesiastico, che godeva di immunità e privilegi di carattere fiscale a tutto discapito degli altri contribuenti. A Napoli i 4/5 delle ricchezze del regno era in mano agli ecclesiastici; in Sicilia essi detenevano circa 1/3 della superficie agraria e forestale. Anche se le cifre erano polemicamente esagerate, non c’è dubbio che le enormi ricchezze della gente di chiesa le conferivano un grosso potere, che costituiva per lo stato un problema assai rilevante (le rendite delle chiese sottoposte alla diretta giurisdizione del re, che rappresentavano solo una parte del patrimonio ecclesiale, sfioravano i 169.000 scudi, erano, cioè, pari al 50% di quanto incassava lo stato in via ordinaria come dotazione fiscale autorizzata dal parlamento.
Le istituzioni religiose detenevano il monopolio delle attività di assistenza e beneficenza ed inoltre l’immunità fiscale si estendeva anche alle proprietà personali dei singoli religiosi secolari ed a quelle dei loro familiari.
Eguale contraddizione si poneva nei confronti dei baroni: si doveva, da un lato, limitarne la potenza per rafforzare i poteri dello stato, ma dall’altro non si poteva governare senza averne l’appoggio. Nella classe baronale si distinguevano due categorie: baronie senza vassallaggio e baronie con vassallaggio. Le prime costituivano la cosiddetta "nuova nobilta’", arricchitasi con i commerci e le attività finanziarie (avvocati, giudici, mercanti, ex-gabelloti), che con l’accesso alla proprietà terriera era entrata a far parte dei ranghi della nobiltà.
La nobiltà con vassallaggio era costituita da un centinaio di famiglie di antico lignaggio, che costituivano l’èlite dell’aristocrazia isolana e che avevano un grande potere non solo perchè disponevano di proprietà immobiliari molto estese, ma soprattutto perchè all’interno dei loro feudi esercitavano la giurisdizione civile e penale su circa 2/3 della popolazione dell’isola (merum et mixtum imperium). Avendo il governo politico, amministrativo, fiscale, giudiziario ed economico all’interno dei loro feudi, costituivano quasi uno stato nello stato, tanto più che essi sedevano in parlamento per diritto ereditario e vi esercitavano un peso notevole.
La forza dei singoli baroni era tanto più grande, quanto più feudi possedevano e questo non solo in termini economici e sociali, ma anche in termini politici, perchè in parlamento la rappresentanza era legata non alle persone, ma ai singoli feudi. Chi possedeva più feudi disponeva di più voti in parlamento, e le lunghe liste di titoli di cui i nobili si fregiavano non era solo vanitosa ostentazione spagnolesca, ma dava la misura del potere di cui il plurititolato godeva in parlamento, secondo una gerarchia consolidata: al primo posto i principi, di seguito duchi, marchesi, conti, baroni. Era importante possedere più titoli e, se i feudi rappresentati in parlamento erano 228, ben 52 di essi erano nelle mani di soli cinque aristocratici.
Ma non era tanto la forza esercitata in parlamento dai baroni ad ostacolare l’esercizio della sovranità regia, infatti il parlamento si riuniva ogni tre o quattro anni, ma piuttosto la giurisdizione feudale, che era praticata routinariamente e che dava ai feudatari più autorità dei ministri del re, il cui potere si esercitava in modo completo solo su una piccola parte dei suoi domini.
Vero è che la maggior parte dei nobili erano coperti di debiti, perchè erano abituati a spendere sistematicamente più delle loro rendite, anche quando esse erano altissime. Inoltre molti di essi erano semianalfabeti e pertanto incapaci di calcolare profitti e perdite su vasta scala, mentre la gestione del rapporto con i gabelloti era affidata a rapaci amministratori, che spesso si arricchivano alle loro spalle. Se è vero che i feudatari avevano ancora saldamente nelle mani il potere politico, avevano perduto gran parte di quello economico, perchè le loro ricchezze erano più spesso spese per acquistare prestigio, anzichè per investimenti produttivi.
Per mantenere inalterata la posizione della famiglia vigeva la consuetudine del maggiorasco ed i figli cadetti il più delle volte prendevano l’abito talare, perchè la vita ecclesiastica aveva i suoi privilegi e conservava loro il rango di cui già godevano. L’esempio fu imitato anche dalla piccola nobiltà con il risultato di un aumento considerevole del numero degli ecclesiastici, che suscito’ le ripetute proteste del parlamento.
I nobili che si trasferivano a Palermo conducevano un tenore di vita più dispendioso e nel contempo trascuravano di più le loro proprietà con il risultato di indebitarsi persino presso i loro gabelloti. Il lusso ed il gioco erano le passioni dominanti della nobiltà, che minacciavano di rovinare parecchie famiglie. L’aristocrazia, dunque, consumava molto e produceva poco, mascherando con il prestigio sociale la debolezza economica.